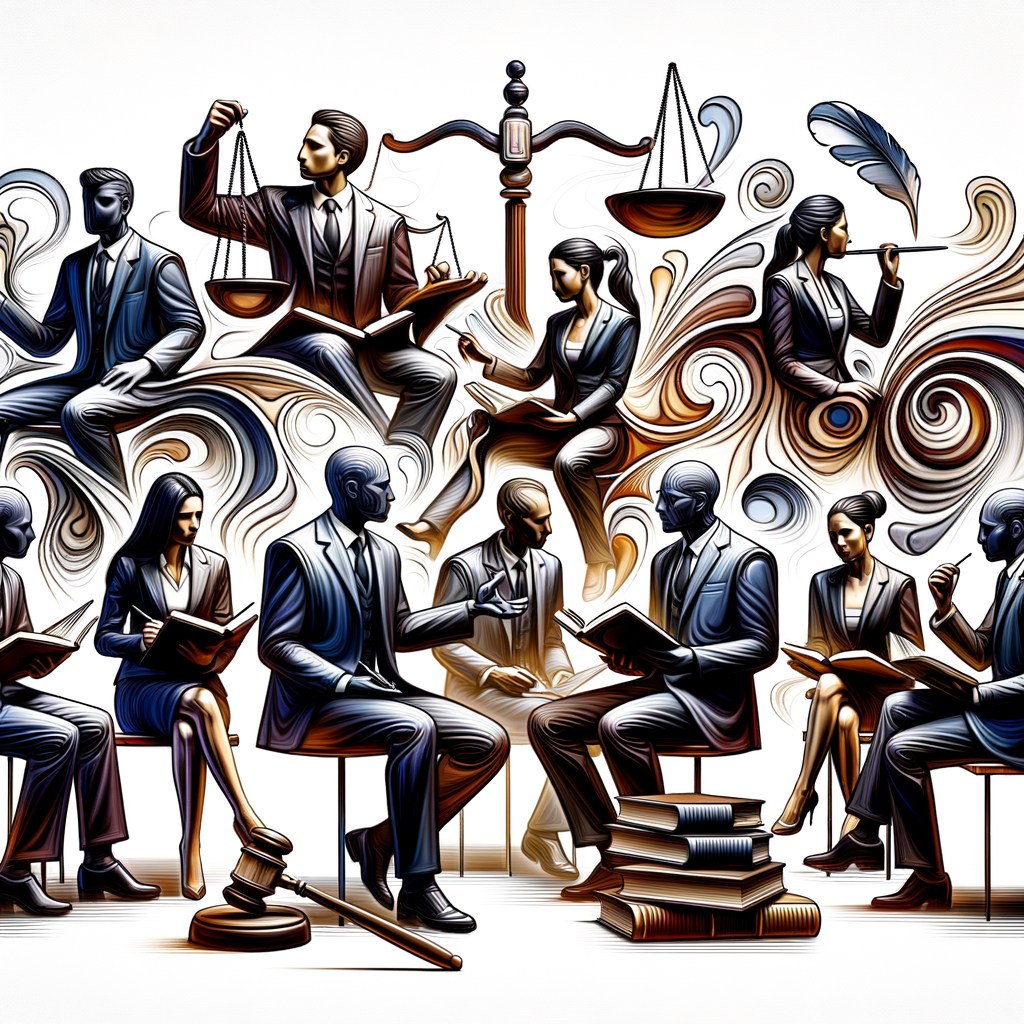
L’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) sul lavoro del giurista, ed in particolare l’IA generativa (LLM) con la sua capacità di produrre testi giuridici coerenti, è molto forte. L’IA generativa, grazie all’apprendimento automatico da enormi database di testi, è in grado di generare contenuti simili a quelli prodotti da un giurista, seppur non sempre corretti o condivisibili, imitando la struttura, la semantica e le peculiarità del linguaggio giuridico.
Questo consente loro di offrire risposte più fluide e realistiche, adattandosi a contesti complessi, con la possibilità di ottenere la predisposizione di contratti o documenti con clausole specifiche, o redigere parti di atti processuali.
Gli LLM tuttavia hanno limiti intrinseci di base, specialmente quando si tratta di usarli per la redazione di atti processuali, perché le premesse su cui si basano i ragionamenti sono predeterminate, a differenza del ragionamento giuridico che si basa sulla ricerca di presupposti condivisi e sostenibili, ed il ragionamento dell’IA segue un percorso unidirezionale, producendo un risultato basato sull’esattezza del processo deduttivo o induttivo, mentre al contrario, il ragionamento giuridico è dialogico e si confronta con diverse prospettive.
A questo proposito, emerge la necessità di una solida preparazione linguistica, logica ed informatica nel giurista che utilizza queste tecniche avanzate per migliorare la resa e la qualità degli atti generati. Esistono infatti modi per ottenere una visione complessa di un problema, presa da diverse prospettive, usando accortamente il prompt engineering.
È dunque importante valutare la formazione di base del personale che utilizza queste tecniche.
